IL PERU' DI FLORA TRISTAN, NONNA DI PAUL GAUGUIN
Guardate un quadro di Paul Gauguin, perdetevi nei suoi rossi, accecatevi dell'arancione, storditevi con il profumo di Paradiso delle sue Tahitiane e aprite questo libro: arriverete a lui, lo prenderete per mano nel suo viaggio verso la follia di un'arte stupenda e annientatrice e scoprirete la donna che, come Paul, anni prima fece dell'amore esasperato per la vita un credo inattaccabile e una forma d'arte nascosta ma sublime.
Il paradiso è altrove (Einaudi, 2003) è l’ultimo romanzo di Mario Vargas Llosa, poliedrico giornalista e scrittore peruviano, che in quest’opera tesse con maestria il racconto di due esistenze speciali nel XIX secolo, quella del pittore Paul Gauguin e di Flora Tristán, sua nonna materna, due esseri liberi, appassionati e profondamente umani, benché ossessionati da una ricerca dell’assoluto che conferisce loro una dimensione tragica.
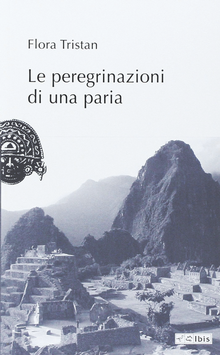 Come spiegò Vargas Llosa in un incontro tenutosi all’Istituto Cervantes di Parigi nel 2004, Il Paradiso è altrove è uno dei suoi progetti più antichi, concepito quando, studente universitario, faceva ricerche sul personaggio di Flora Tristán. Leggendo Peregrinazioni di una paria della stessa Flora, lo scrittore fu incantato dalle avventure di questa donna che, abbandonato il focolare domestico a Parigi, scappò in Perù immergendosi in un mondo che le era estraneo. Negli anni sessanta la bibliografia riguardante Flora Tristán era scarsa, ma Vargas Llosa sentiva comunque l’urgenza di scrivere qualcosa su di lei, almeno fino a quando un altro personaggio non si impose alla sua attenzione. Si trattava di Paul Gauguin, proprio l’eccelso pittore, che figurava costantemente citato da tutti gli studiosi che si erano occupati di Flora Tristán. Cominciarono così le letture su Gauguin, la sua vita, la sua opera di pittore, il suo genio e si delinearono le prime affinità di carattere tra nonna e nipote: l’anticonformismo, la volontà di sfidare la loro epoca e l’idealismo esasperato che faceva anelare entrambi a mondi idilliaci.
Come spiegò Vargas Llosa in un incontro tenutosi all’Istituto Cervantes di Parigi nel 2004, Il Paradiso è altrove è uno dei suoi progetti più antichi, concepito quando, studente universitario, faceva ricerche sul personaggio di Flora Tristán. Leggendo Peregrinazioni di una paria della stessa Flora, lo scrittore fu incantato dalle avventure di questa donna che, abbandonato il focolare domestico a Parigi, scappò in Perù immergendosi in un mondo che le era estraneo. Negli anni sessanta la bibliografia riguardante Flora Tristán era scarsa, ma Vargas Llosa sentiva comunque l’urgenza di scrivere qualcosa su di lei, almeno fino a quando un altro personaggio non si impose alla sua attenzione. Si trattava di Paul Gauguin, proprio l’eccelso pittore, che figurava costantemente citato da tutti gli studiosi che si erano occupati di Flora Tristán. Cominciarono così le letture su Gauguin, la sua vita, la sua opera di pittore, il suo genio e si delinearono le prime affinità di carattere tra nonna e nipote: l’anticonformismo, la volontà di sfidare la loro epoca e l’idealismo esasperato che faceva anelare entrambi a mondi idilliaci.Parigi a notte fonda, le strade buie, i lampioni sono spenti ma l’imbarcadero sulla Senna è brulicante di persone: da questo scenario prende avvio la narrazione che si snoda per ventidue capitoli, fluida, vivida, sapientemente costruita con flashback e rimandi a luoghi, fatti e persone spesso complessi. In questo gioco di salti nel tempo e nello spazio si arriva in Perù, Paese natale dell’autore ma anche, coincidenza, una terra che tanta parte ebbe nella formazione di Gauguin. Il pittore trascorre qui i primi anni della sua infanzia e, anche se la relazione sfugge ai più, quei luoghi influenzarono fortemente i suoi quadri tahitiani. Flora invece resta in Perù solo dieci mesi, alla ricerca della sua parte di eredità, ma quel breve periodo la cambia profondamente, trasformandola in una rivoluzionaria, una ribelle che, preso atto della sua condizione di donna oppressa, decide di adoperarsi con tutte le forze per l’affrancamento delle donne e dei più deboli dalla schiavitù di mariti violenti e padroni senza scrupoli.
Flora Tristán a quattro anni perde il padre e inizia una vita di abusi e privazioni, segnata da un matrimonio violento da cui fugge, rifiutando di essere l’appendice di un uomo, abbandonando una figlia e trasformandosi così, per la società dell’epoca, in una donna colpevole e disgraziata. Sofferenza dopo sofferenza Flora comincia però a rialzarsi, studia, lavora, diventa indipendente e si fa portavoce delle istanze di chi non ha diritti, gira la Francia in lungo e in largo, parla con gli operai più poveri e con i loro padroni divulgando le sue idee rivoluzionarie, non si risparmia e quando il male fisico le rende la vita un inferno non si arrende.
Paul Gaugain è un agente alla Borsa di Parigi, vive con la moglie e i figli, conduce una vita agiata, gode della stima di famigliari e amici, ma a poco a poco un profondo disagio si insinua nella sua anima. A trent’anni conosce l’arte della pittura e, come folgorato da una pulsione incontrollabile, abbandona ogni legame con la sua vita borghese e si imbarca per i Mari del Sud. Prima a Panama, poi in Martinica e a Tahiti, Gauguin si trasforma in un selvaggio alla ricerca dell’essenza della vita, incarnata secondo il pittore francese dai nativi di quei luoghi ancora vergini e primitivi: gente priva di sovrastrutture e condizionamenti, libera e felice.
Ma quanta verità c’è in questo libro e quanta finzione? Spiega l’autore che si tratta di un romanzo in cui la finzione prevale, in un contesto di veridicità in cui i riferimenti storici, politici e temporali tendono comunque all’obiettività. Un altro aspetto importante da considerare, continua Vargas Llosa, è il punto di vista narrativo. Ci sono parti del racconto, infatti, in cui il narratore onnisciente cede la parola ad un altro narratore che interviene nella storia apostrofando i protagonisti con un “Tu” diretto, che apparentemente lo rende personaggio esso stesso. In realtà, il narratore non entra in prima persona nella vicenda, ma sono Flora Tristán e Gauguin a parlare a se stessi con quel “Tu”, attraverso un meccanismo che permette all’autore di penetrare nell’intimità delle sue creature, nella loro coscienza distante da tutto, protesa unicamente a raggiungere “Il paradiso altrove”.
Perché, come dice l’epigrafe di Paul Valery in apertura del libro “che ne sarebbe, dunque, di noi senza l’aiuto di quel che non esiste?”
